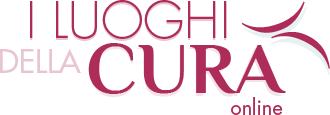Il rapporto tra l’uomo e la musica è una delle relazioni più antiche, profonde e universali della storia dell’umanità. Fin dai tempi più remoti, la musica ha accompagnato riti, evoluzioni sociali e culturali. Nel suono e nella musica l’uomo, da sempre, ha cercato strumenti per esprimere sé stesso, per comunicare, per orientarsi nell’ambiente, per celebrare momenti e fasi della vita significative1, per rapportarsi con la propria spiritualità. Questi aspetti fanno riflettere sull’esistenza dell’intimo legame che, fin dalle origini più remote, esiste fra la natura umana e l’esperienza sonora, rivelando quasi un bisogno intrinseco dell’uomo di rapportarsi con il suono per connettersi alla vita.
Gli interventi di natura sonoro musicali e la musicoterapia
Il suono accompagna la persona in tutto il percorso esistenziale, dalla vita prenatale fino all’ultimo respiro: esso esercita una potente azione sul piano psico-corporeo2, veicola emozioni, connotando relazioni e ambienti, modula i toni della comunicazione, stimola i sensi e le funzioni cognitive3. Il suono e la musica oggi vengono sempre più utilizzati, in varie forme e modalità, per prendersi cura di sé stessi e rappresentano strumenti particolarmente efficaci nelle relazioni con le persone che vivono situazioni di fragilità, tra cui gli anziani. Sono infatti molti gli interventi di natura sonoro-musicale che vengono proposti agli anziani in vari contesti e servizi, ma non tutti possono essere definiti musicoterapia.
Nell’APSP Margherita Grazioli è stato elaborato un approccio sonoro-musicale alla persona anziana, rivolto in particolare a chi è affetto da deterioramento cognitivo, nell’ottica di una presa in carico globale4, mediante la realizzazione di diverse tipologie di intervento sonoro-musicale integrate fra loro e applicate ai vari momenti di cura tra cui interventi assistenziali, trattamenti terapeutici e riabilitativi e attività ludiche e sociali. L’Approccio Musicale Globale alla Persona con demenza (Raglio et al., 2014; Filippi, 2015) nell’esperienza dell’APSP Margherita Grazioli è gestito e coordinato dal musicoterapeuta e realizzato in collaborazione con altri caregiver (OSS, fisioterapisti, infermieri, animatori, familiari, volontari, etc.). L’attenzione di questo approccio non è solo rivolta alla cura del benessere della persona anziana ma anche al sostegno dei caregiver, offrendo loro nuovi strumenti e nuove prospettive della relazione di cura.
Perché utilizzare il suono e la musica nella cura del benessere della persona?
L’utilizzo del suono e della musica nella cura del benessere della persona ha basi neuroscientifiche e psicologiche solide e significative. Studi e ricerche riportano evidenze in merito all’azione attivante dell’elemento sonoro-musicale rispetto a numerose aree del cervello (Koelsch, 2014; Levitin, 2009): fra queste sono indicate in particolare le aree adibite alla percezione e all’elaborazione delle emozioni, alle funzioni motorie e alle funzioni cognitive (Altenmuller et al., 2009). Anche a livello neurochimico è dimostrato che la musica aumenta la produzione e l’attività di ormoni e neurotrasmettitori relativi ai meccanismi di ricompensa e piacere, portando benefici sul tono dell’umore, riducendo lo stress, aumentando il senso di fiducia e la motivazione, riducendo la percezione del dolore (Chanda & Levitin, 2013). Altri studi evidenziano effetti positivi sulla pressione arteriosa, sulla frequenza cardiaca e sulla frequenza respiratoria (Loomba et al., 2012). Sul piano psicologico è segnalato l’importante ruolo che l’elemento sonoro-musicale esercita sullo sviluppo psico-cognitivo della persona, nella vita prenatale e in particolare nelle prime fasi di vita dopo la nascita5dando una sorta di imprinting alle modalità di espressione delle emozioni, di comunicazione, dei processi affettivi e relazionali (Stern, 1985; Trevarthen & Aitken, 2001).
La ricerca dimostra inoltre che, anche in presenza di importanti patologie degenerative, come ad esempio la demenza, il suono e la musica mantengono un ruolo centrale come strumenti facilitanti l’espressione emotiva e quindi la comunicazione e la relazione, stimolando nello stesso tempo le funzioni cognitive e motorie. È anche dimostrato che le funzioni cognitive legate al rapporto con la musica rimangono preservate nel tempo per un periodo maggiore rispetto ad altre (Fornazzari et al., 2006) tra cui, ad esempio, la memoria musicale, la percezione musicale, la risposta emotiva all’evento sonoro-musicale, l’attivazione e la coordinazione motoria in particolare sollecitata dalla componente ritmica. Nell’ambito dell’invecchiamento, questi presupposti neuroscientifici e psicologici hanno determinato l’elaborazione di diversi interventi sonoro-musicali nel campo della prevenzione, della riabilitazione e/o della terapia.

La finalità generale che accomuna tutte queste attività è relativa al preservare e/o migliorare la qualità della vita dell’anziano accompagnandolo nei cambiamenti fisici, cognitivi, psico-emotivi, attraverso esperienze sonoro-musicali mirate. Un altro importante tema legato all’utilizzo del suono e della musica nell’ambito dell’invecchiamento riguarda come il suono e la musica possano rappresentare, anche per il caregiver, importanti strumenti per ripensare e rimodulare la relazione di cura nella quotidianità6, favorendo processi di condivisione perlopiù emotivi che permettono di mantenere un buon livello di contatto e interazione, bypassando i deficit cognitivi. L’elemento sonoro-musicale può aiutare inoltre il caregiver a curare l’ambiente sonoro degli spazi di vita quotidiana, facilitando momenti assistenziali in cui la persona può presentare maggiore disagio e difficoltà.
Prendersi cura della persona fra attività musicali e musicoterapia
Il suono e la musica hanno effetti molto potenti sul funzionamento neurofisiologico, ma non per questo sono da considerarsi terapeutici tout court e, di conseguenza, non è possibile parlare di musicoterapia semplicemente quando un’attività musicale qualunque viene associata a obiettivi di benessere. Quale utilizzo del suono e della musica è da considerarsi musicoterapia e quale invece attività musicale?
La musicoterapia nasce come disciplina vera e propria circa 50 anni fa e viene inserita fra le cosiddette terapie complementari. La World Federation of Music Therapy, già nel 1996 in occasione del VIII congresso mondiale di musicoterapia e poi ancora nel 2011, ha elaborato una definizione di musicoterapia, per fare chiarezza e quindi evitare confusione sia sul piano applicativo che a livello dell’etica professionale: “La musicoterapia è l’uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti medici, educativi e quotidiani con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la loro salute e il loro benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. La ricerca, la pratica, l’educazione e la formazione clinica in musicoterapia sono basate su standard professionali secondo contesti culturali, sociali e politici”.
Approfondendo i contenuti e i temi annunciati da questa definizione, emergono quelli che possiamo definire i presupposti fondamentali che delineano l’intervento di musicoterapia, ovvero:
- la presenza di un musicoterapeuta, quale operatore qualificato che ha effettuato un percorso di studio in materie medico/sanitarie, psico-sociali, educative, musicali e musicoterapiche;
- la presenza di un setting strutturato: teorie di riferimento, metodo applicativo, tecniche impiegate, patto terapeutico;
- la definizione di obiettivi terapeutici elaborata insieme ai curanti di riferimento, la persona coinvolta (quando possibile) e/o le persone di riferimento della stessa.
Le attività musicali invece non necessitano della presenza di un musicoterapeuta e non prevedono un setting strutturato come descritto. Esse hanno comunque un ruolo e un significato importante di occasioni di benessere, legate al qui ed ora del momento; non perseguono obiettivi terapeutici, utilizzano contenuti musicali strutturati preparati a priori7.
Un approccio sonoro-musicale alla persona: l’esperienza della APSP Margherita Grazioli
Le diverse tipologie di intervento sonoro-musicale possono coesistere in un unico approccio sonoro/musicale alla persona, realizzato da differenti caregivers per una presa in carico globale dell’anziano. Questo è ciò che è stato pensato ed elaborato presso l’APSP Margherita Grazioli: il musicoterapeuta del servizio, in collaborazione con le diverse figure professionali dell’Equipe della RSA (in particolare OSS, fisioterapisti, educatori e animatori), ha elaborato un metodo di intervento con il suono e la musica a più livelli della presa in carico che vanno dalla cura della relazione durante le ADL, nella quotidianità, alla cura dell’ambiente sonoro degli spazi di vita sino alla realizzazione di interventi terapeutici e riabilitativi mirati a obiettivi specifici. Gli interventi previsti dall’Approccio Musicale Globale alla Persona con demenza sono: a) trattamento di musicoterapia b) attività musicali c) il canto del caregiver d) l’ascolto musicale individualizzato e) la musica di sottofondo (Tabella 1).
Gli aspetti comuni che stanno alla base di queste attività e che costituiscono il pensiero guida dell’approccio, sono:
- la ricerca del miglior benessere possibile della persona attraverso la proposta di esperienze sonoro-musicali personalizzate che preservino l’identità e le caratteristiche personali, con uno sguardo duplice fra passato e presente;
- il concetto di persona legato alla dimensione non verbale/sonoro-musicale. Dal latino per – sonare, la persona è uno strumento musicale, esprime sé stessa attraverso il suono (frequenza/timbro/ritmo/intensità di voce, respiro, movimento, battito cardiaco, etc.). Essere consapevoli di questo guida nella comunicazione e nella relazione, osservando ed ascoltando sia se stessi (sostenendo la consapevolezza del caregiver del proprio funzionamento e delle proprie modalità di espressione e relazione) che la persona di cui ci si prende cura, attraverso l’attenzione ai messaggi non verbali e paraverbali;
- la cura della relazione valorizzando soprattutto l’espressione, il contatto e la comunicazione a livello non verbale, quindi emotivo, corporeo, sensoriale, affettivo;
- la cura dell’ambiente sonoro in cui ci si prende cura della persona (qualità e tipologie di stimoli sonori, valorizzazione del silenzio come elemento fondamentale di benessere e della comunicazione a un livello profondo);
- il concetto di dosaggio degli stimoli (personalizzazione degli ambienti sonori di vita e delle modalità di interazione).

Gli interventi di musicoterapia (MT) sono caratterizzati dall’interazione sonoro-musicale tra la persona con demenza e il musicoterapeuta: si tratta di una sorta di dialogo sonoro, di una relazione d’aiuto in cui al posto delle parole si utilizzano i suoni della voce, del respiro, degli oggetti sonori oppure brani musicali suonati dal vivo o registrati, con o senza testo, al fine di stabilire un contatto emotivo e una relazione che faciliti la persona nell’espressione delle proprie emozioni, energie e pensieri. Uno dei focus di questo intervento è quello di ascoltare, osservare, leggere (come una partitura!) la persona nella sua globalità e valorizzare le parti sane8favorendo un ruolo attivo nella relazione terapeutica nel pieno rispetto della libertà e dell’autodeterminazione). Gli interventi di musicoterapia sono gestititi dal musicoterapeuta; vengono realizzati all’interno di un setting strutturato e personalizzato (stanza di musicoterapia oppure spazio riservato secondo il modello di intervento di riferimento di natura psicologica e/o neuroscientifica che definisce la cornice teorico-applicativa). Sono orientati a obiettivi definiti insieme all’èquipe pluriprofessionale di riferimento, ad esempio per ridurre gli stati di agitazione, aumentare il tono dell’umore, per il trattamento dell’ansia e della depressione, nella presa in carico di aspetti comportamentali legati a stato di isolamento sociale, apatia.

Le sedute di musicoterapia hanno una durata che può variare dai 20 ai 45 minuti circa, con cadenza settimanale oppure bisettimanale, a seconda del progetto personalizzato. Talvolta, se previsto, alle sedute può partecipare anche il caregiver (familiare) allo scopo di supportarlo nel trovare nuove modalità di interazione e gestione della relazione con il proprio caro, proprio attraverso la mediazione e la condivisione dell’esperienza sonoro-musicale. Negli ultimi anni, l’intervento di musicoterapia viene proposto anche nella fase di accompagnamento nel fine vita, quindi ricalibrando approccio e setting su obiettivi legati al rilassamento, alla gestione del dolore, alla condivisione di aspetti legati alla spiritualità, al sostegno e all’accompagnamento dei familiari. Gli interventi musicali previsti dall’approccio musicale globale consistono invece in attività musicali generiche con caratteristiche non contestualizzabili in ambito terapeutico: si tratta di esperienze sonoro-musicali gestite da animatori, operatori, musicisti, volontari, rivolte perlopiù a gruppi di persone e che hanno l’obiettivo di offrire spazi di benessere nel qui ed ora utilizzando il canto (ad esempio canti della memoria e della biografia), il movimento associato alla musica, l’ascolto musicale finalizzato a recupero di ricordi e memorie, alla condivisione di emozioni, sensazioni, pensieri legati alla musica. Questi incontri hanno generalmente cadenza settimanale e durata di circa 45 minuti.
Il canto del caregiver consiste nell’utilizzo, da parte dell’operatore oppure del familiare, della voce proponendo melodie improvvisate e/o strutturate (canzoni significative per la persona). La voce è uno strumento che avvicina molto a livello emotivo ed affettivo, facilita il contatto e la relazione con la persona con demenza creando un clima sereno e di fiducia aldilà degli ostacoli alla comunicazione determinati dai deficit cognitivi. Il canto del caregiver può essere utilizzato in particolare nei momenti assistenziali (risveglio, mobilizzazione, bagno assistito, etc.) che spesso sono fonte di stress, disagio e disorientamento e a cui la persona può rispondere con comportamenti di difesa, opposizione, aggressività. Nell’utilizzo della vocalità il caregiver può trovare un valido strumento per facilitare la comunicazione e la relazione con la persona, per avere e dare un sostegno non verbale nella relazione di cura.

L’ascolto musicale individualizzato consiste in una proposta di playlist basate sull’identità sonoro-musicale della persona fragile (mondo emotivo, preferenze sonoro musicali) e su obiettivi personalizzati (tra cui, ad esempio, favorire il riposo/rilassamento, aiutare la persona a gestire la percezione del dolore, stimolare l’attenzione e l’attivazione psico-emotiva, ridurre disturbi del comportamento durante le ADL, etc.). La playlist viene elaborata dal musicoterapeuta e somministrata dal caregiver secondo un programma strutturato in cui sono definite modalità, tempi e durata in base al progetto e agli obiettivi personalizzati. L’ascolto musicale individualizzato, negli ultimi anni, viene proposto anche nel percorso di accompagnamento nel fine vita: questo intervento è stato valutato molto utile e significativo in particolare nel sostenere un clima di sacralità della fase delicata e dolorosa che tutte le persone coinvolte vivono accanto al morente (familiari e personale), una sacralità che connota anche l’ambiente-stanza con suoni e musiche che richiamano all’attenzione, al silenzio, al rispetto all’intimità del momento esistenziale, una sacralità in cui le parole lasciano lo spazio a silenzi e suoni.
La musica di sottofondo (la cosiddetta background music) prevede l’utilizzo di musica preregistrata selezionata dal musicoterapeuta e diffusa in un preciso ambiente e in una specifica situazione (pranzo, momenti di riposo, etc.), o in assenza di specifiche attività. È rivolta a spazi comuni, quindi a gruppi di persone che li frequentano. L’obiettivo consiste nel miglioramento del clima emotivo generale cercando di favorire la serenità, garantire un senso di accoglienza degli spazi e prevenire il disturbo del comportamento, favorendo le relazioni.

L’Approccio musicale globale può essere definito come una sorta di utilizzo funzionale del suono, del silenzio e della musica, mirato, dosato e bilanciato sui bisogni della persona e dei caregiver.
Conclusioni
L’utilizzo dell’elemento sonoro-musicale come parte integrante della relazione di cura sostiene la persona anziana nella propria identità, nella memoria dei propri ricordi, nell’abitare il proprio corpo in cambiamento, nel sentirsi ascoltata e mantenuta in una relazione che diventa sempre più suono, silenzio e musica, in una dimensione profonda, di vissuti non più esprimibili a parole. Il suono e la musica sostengono anche i caregiver (familiari, operatori) nel trovare nuove forme e modalità di contatto, di comunicazione e di attività con la persona fragile, accompagnati, sostenuti e guidati da una terza presenza che funge da mediatore e facilitatore e che colora emotivamente e sensorialmente anche l’ambiente in cui accade l’incontro.
L’applicazione dell’Approccio Musicale Globale alla Persona con demenza presso l’APSP M. Grazioli ha dimostrato l’efficacia e i significati che emergono dall’esperienza di cura attraverso la dimensione non-verbale/sonoro-musicale nella la presa in carico globale della persona/paziente (mente, anima, corpo), il sostegno alle famiglie e al personale.
Note
- come la nascita, morte, eventi sociali, cura delle malattie…
- attivazione, rilassamento
- tra cui attenzione, memoria, movimento
- con riferimento agli aspetti psico-emotivi-relazionali, sensoriali, cognitivi, corporei/motori
- In particolare nella relazione madre-bambino: modulazione della voce, nel contatto, nel movimento
- nella comunicazione e nella relazione, con un ambiente sonoro e/o attività mirate)
- Nella pratica di molti servizi che si rivolgono agli anziani queste proposte sonoro-musicali di diversa tipologia sono frequentemente attuate e hanno obiettivi generici legati al benessere psico-fisico della persona: a titolo di esempio queste attività sovente ricomprendono l’attività motoria associata alla musica, canto in gruppo, cantare canzoni della memoria, esercizi cognitivi basati sull’utilizzo di materiale musicale, la pratica strumentale, l’ascolto musicale, l’ascolto della musica come pratica di rilassamento. Le attività musicali rivolte agli anziani hanno una forte connotazione sociale, ludico-ricreativa, di stimolazione di ricordi legati alla musica, di attivazione motoria nell’ottica del piacere legato al movimento guidato dal suono e dal ritmo.
- (ad esempio l’espressione non verbale/sonoro-musicale, la qualità dell’energia e dell’intenzionalità comunicativa, etc.)
Bibliografia
Altenmuller M.J., Munte T.F., Schneider S. (2009), Neural reorganization underlies improvement in stroke-induced motor dysfunction by music-supported therapy, in Ann N Y Acad Sci, 2009, Vol. 1169, pp.395-405.
Chanda ML, Levitin DJ. (2013), The neurochemistry of music, in Trends Cogn Sci;17(4):179–193.
Filippi S. (2015), Approccio musicale globale alla persona affetta da demenza, Musica&Terapia, Cosmopolis s.n.c., 32.
Fornazzari L, Castle T, Nadkarni S, Ambrose M., Miranda D, Apanasiewicz N., Phillips F. (2006), Preservation of episodic musical memory in a pianist with Alzheimer disease, in Neurology;66(4):610–611.
Fornazzari L., Castle T., Nadkarni S., Ambrose M., Miranda D., Apanasiewicz N., Phillips F. (2006), Preservation of episodic musical memory in a pianist with Alzheimer disease, Neurology;66(4):610–611.
Koelsch S. (2014), Towards a neural basis of music-evoked emotions, in Trends Cogn Sci. 2010;14(3):131–137.
Levitin D.J, Tirovolas A.K. (2009), Current advances in the cognitive neurosci¬ence of music, in Ann N Y Acad Sci.;1156:211–231.
Loomba R.S., Arora R., Shah P.H., Chandrasekar S., Molnar J. (2012), Effects of music on systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and heart rate: a meta-analysis, in Indian Heart J.;64(3):309–313.
Raglio A., Filippi S., Bellandi D., Stramba-Badiale M. (2014), Global music approach to persons with dementia: evidence and practice, in Clin Interv Aging;9:1669-76.
Stern D. (1985), Il mondo interpersonale del bambino, Bollati Boringhieri.
Trevarthen C., Aitken K.J. (2001), Infant intersubjectivity: research, theory and clinical application, in J Child Psychol Psychiatry;42(1):3–48.