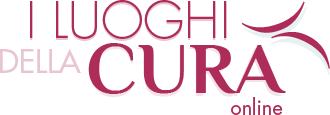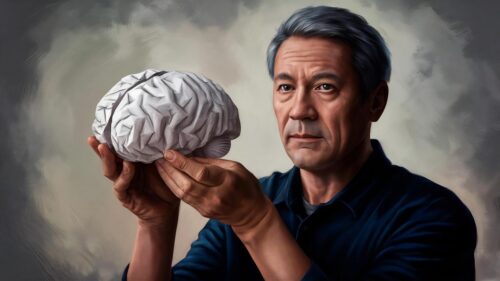
Senza evidenza non c’è scienza
Edmund Husserl
Stiamo assistendo a un ritorno di attenzione, sia pure un po’ timido, sull’argomento delle demenze a esordio giovanile (cioè prima dei 65 anni, per definizione corrente): non a caso, l’editoriale di commento a uno degli articoli qui presi in considerazione (Hendriks, et al., 2024) si intitola “demenza a esordio giovanile: nuove consapevolezze per un problema poco apprezzato”.
Le dimensioni del problema
Una recente revisione sistematica con meta-analisi (Hendriks, et al., 2021) ha preso in considerazione 74 studi, che hanno incluso 2.760.379 soggetti. La prevalenza globale standardizzata per età (cioè il numero delle persone ammalate, rilevato in un determinato momento) della demenza a esordio precoce era conteggiata come 119 ogni 100.000 persone di età compresa tra 30 e 64 anni, portando a una stima di 3,9 milioni. Le quote crescono da 1,1 ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 30 e 34 anni a 77,4 ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 60 e 64 anni1.
Viceversa, puntando ai nuovi casi che si verificano in un determinato arco di tempo (incidenza), in una indagine simile parallela su 60 articoli, condotta da autori in parte coincidenti, i tassi globali di incidenza standardizzati per età salgono da 0,17/100.000 nella fascia di età 30-34 anni a 5,14/100.000 nella fascia di età 60-64 anni, dando un tasso totale di incidenza globale, standardizzato per età, di 11 per 100.000 nella fascia di età 30-64 anni. Ciò corrisponde a 370.000 nuovi casi all’anno, in tutto il mondo, di demenza a esordio giovanile (Hendriks, et al., 2023).
Studiosi dell’Università di Pechino hanno pubblicato un articolo (Li, et al., 2024) adoperando i dati della serie 2021 del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD). Questi dati, a seconda delle fonti, considerano come età di esordio precoce un’età inferiore ai 65 anni oppure inferiore ai 70 anni, in una prospettiva mondiale. Sottolineando che l’impatto della demenza a esordio precoce non dovrebbe venire sottovalutato, gli autori propongono il primo studio che stima sistematicamente il peso della demenza globale in individui (più giovani) in base al livello nell’indice socio-economico, a regione, genere ed età. L’indice socio-economico è calcolato in base a fertilità, scolarità e reddito pro capite.
I risultati esprimono che negli ultimi 30 anni la prevalenza globale, l’incidenza, la mortalità e il carico di invalidità dovuti a demenza, in individui di età inferiore ai 70 anni, sono raddoppiati, insieme a una notevole accelerazione nell’ultimo decennio del tasso di crescita del carico di casi di demenza a esordio precoce.
I dati sulla prevalenza e l’incidenza per gli individui di età inferiore ai 65 anni, rispettivamente pari a 7,76 milioni e 1,38 milioni nel 2021, superano nettamente le stime precedenti. Il carico di demenza sotto i 70 anni è aumentato in tutte le fasce d’età nei Paesi a basso indice socio-economico nel periodo 1990-2021, e più l’età è avanzata, più rapido è l’aumento. Poiché più di un terzo dei casi di demenza a esordio precoce ha origine nei Paesi a indice medio, l’aumento di tale carico in questi Paesi determinerà il carico globale. Il peso relativo (proporzione % della demenza tra gli infra70enni, sul totale delle demenze, a livello mondiale 1990-2021) è massimo nei Paesi a basso indice socio-economico, minimo in quelli con indice socio-economico elevato.
Passando dalle % ai numeri assoluti, il numero dei casi totali di demenza tra gli infra70enni, sul totale delle demenze, nel periodo 1990-2021 è minimo nei Paesi a basso indice socio-economico, massimo in quelli con indice da medio a elevato. In tutto il mondo si contavano 13,14 milioni di casi sotto i 70 anni nel 2021 (prevalenza), di cui 2,28 milioni di nuovi casi nel 2021 (incidenza).
Fattori di rischio e fattori di protezione
Come sottolineato da ricercatori affiliati all’Università di Wuhan (Li, et al., 2023), l’importanza di questo argomento è stata ampiamente trascurata, almeno rispetto alla forma “classica” a esordio senile.
La ricerca degli studiosi cinesi è stata la prima a quantificare le complesse relazioni tra stato socio-economico, fattori legati allo stile di vita e rischio di demenza precoce (intesa “canonicamente” come a esordio prima dei 65 anni). In quella ricerca, tra il 2007 e il 2010 erano state analizzate 257.345 persone di età < 60 anni e 294.133 ultra65enni, arruolate nella biobanca del Regno Unito, seguite per circa 12 anni: vennero diagnosticati rispettivamente 502 e 5.768 nuovi casi di demenza. Lo stato socio-economico è stato stimato in base a scolarità, occupazione e reddito; lo stile di vita in base a fumo, consumo eccessivo di alcol, attività fisica e dieta.
L’associazione con lo stato socio-economico si è dimostrata più pronunciata per il rischio di demenza a esordio precoce che per il rischio di demenza a esordio tardivo. Rispetto agli individui con uno status socio-economico elevato, quelli con status basso avevano un rischio più di 3 volte maggiore di sviluppare una forma di demenza a esordio precoce. Anche lo stile di vita gravava sul rischio. Stato socio-economico e stile di vita sembravano influire indipendentemente sul rischio: solo una piccola parte (3,2 %) dell’associazione tra status socio-economico e demenza a esordio prima dei 65 anni era mediata dallo stile di vita complessivo. Il gruppo maggiormente esposto era costituito da individui di basso status socio-economico con stili di vita non sani, che avevano un rischio maggiore del 440% rispetto agli individui di alto status socio-economico con stili di vita sani.
Nell’editoriale di accompagnamento (Filippini, Vinceti, 2023), due studiosi affiliati all’Università di Modena e Reggio Emilia – e parallelamente anche a quelle di Berkeley e Boston, rispettivamente – hanno sottolineato che la promozione di uno stile di vita sano da sola potrebbe non ridurre sostanzialmente la disuguaglianza socio-economica nella demenza a esordio precoce e nel rischio di demenza a esordio tardivo.
Uno studio su registri amministrativi dei nati in Nuova Zelanda tra il 1928 e il 1967 (Richmond-Rakerd, et al., 2022) ha preso in considerazione 1.711.386 soggetti (50,6 % maschi) di età fra 21 e 60 anni all’inizio di un’osservazione di 30 anni (1988-2018). Rispetto a quelli senza disturbi mentali, gli individui con disturbi mentali presentavano un rischio maggiore di oltre 4 volte di sviluppare successivamente una demenza. L’associazione valeva lungo l’intero spettro di età, e per entrambi i sessi, anche dopo correzione per patologie croniche pre-esistenti, e per la deprivazione socio-economica. La forza dell’associazione spaziava da quasi 3 volte per i disordini neurotici a oltre 6 volte per quelli psicotici. Ancora, l’associazione si applicava alla demenza di Alzheimer (rischio di oltre 2 volte e mezza) ma ancor più alle altre forme di demenza (rischio di quasi 6 volte).
Infine, una collaborazione fra studiosi di università inglesi e di Maastricht – in Olanda – pubblicata in linea (Hendriks, et al., 2024), ha analizzato i dati della biobanca del Regno Unito su 356.052 infra65enni bilanciati per sesso, di età media 54,6 ± 7 anni, seguiti per 8 anni, totalizzando 2.891.409 persone-anno di osservazione, con 485 nuovi casi di demenza occorsi. Numerosi potenziali fattori di rischio / protezione (in totale 39) sono stati raggruppati in 8 categorie: socio-demografici, genetici, stile di vita, ambientali, biomarcatori ematici, cardio-metabolici, psichiatrici, e di altra natura (funzionalità renale, storia di traumi cranici, disfunzione tiroidea, artrite reumatoide).
I 15 fattori – modificabili e non – filtrati dall’analisi statistica sono stati suddivisi in 2 macrocategorie: nocivi e protettivi. I 12 fattori nocivi individuati sono: basso status socio-economico, omozigosi ε4ε4 per l’apolipoproteina E, disturbo da uso di alcol, isolamento sociale, carenza di vitamina D (concentrazioni plasmatiche < 10 ng/mL), alti livelli di proteina C reattiva (concentrazioni plasmatiche PCR > 1 mg/dL), deficit uditivo, ipotensione ortostatica, ictus, diabete, malattie cardiache, depressione. I 3 fattori protettivi individuati sono: scolarità più elevata (livello accademico o professionale), minore fragilità fisica (forza di prensione della mano superiore ai valori normativi: ≥ 25 kg per le femmine, ≥ 40 kg per i maschi), consumo alimentare di alcol2.
Allo scopo di ridurre il rischio di confondere cause ed effetti (la minaccia di “causalità inversa” incombe sempre sugli studi osservativi), l’approfondimento dell’analisi è stato ristretto ai casi in cui la demenza veniva diagnosticata almeno 3 anni dopo l’inizio dell’osservazione basale. Esclusi così 77 partecipanti, la condizione di omozigosi ε4ε4, il disturbo da uso di alcol (DUA – DSM 5), i livelli di PCR e l’ipotensione ortostatica non sono più risultati statisticamente associati alla demenza a esordio precoce. Il deficit uditivo, come pure le malattie cardiovascolari, rivestono un rilievo maggiore nei “giovani” che negli anziani.
In generale, esistono importanti differenze tra i fattori di rischio noti per la demenza a esordio tardivo, e quelli emersi nello studio in questione per le forme a esordio giovanile. Rispetto a quelle a esordio senile, alle forme a manifestazione precoce è associato solo un numero limitato di fattori collegati allo stile di vita: consumo di alcol (con significato ambivalente e incostante), carenza di vitamina D e isolamento sociale. Un’ipotesi interpretativa ragionevole è che gli effetti relativi dei fattori legati allo stile di vita potrebbero aver avuto meno tempo per contribuire alle patologie sottostanti correlate alla demenza.
Note patologico-cliniche
Nelle forme a esordio giovanile, il substrato patologico è parzialmente diverso da quello delle forme a esordio tardivo, con maggiore atrofia delle sostanze grigia e bianca nelle regioni posteriori, atrofia corticale più pronunciata a livello temporale e parietale, relativo risparmio ippocampale, specie nelle forme a esordio precoce non-amnestiche; vi è inoltre una tendenza a un maggiore carico amiloide a prescindere dal fenotipo clinico, cioè dalle modalità di espressione in sintomi e segni. La malattia di Alzheimer conserva il primato solo relativo, e non più assoluto, mentre aumentano le quote di altre forme patologiche, in particolare quella fronto-temporale.
Aumenta il peso della componente genetica, ma senza enfatizzare questo aspetto al di là del dovuto: un’aggregazione familiare è presente in un caso di demenza di Alzheimer su 4, a prescindere dall’età, per cui la maggior parte di queste forme è sporadica. Se è vero che quasi tutte le forme familiari di demenza di Alzheimer hanno esordio precoce, le forme familiari viceversa rendono conto solo di una piccola frazione del totale delle demenze a esordio precoce, di cui 13% sono trasmesse come tratto autosomico dominante.
Quanto alle espressioni cliniche, la maggioranza assoluta dei pazienti con demenza di Alzheimer precoce presenta una manifestazione tipica (deficit di memoria, con frequente depressione). Nei rimanenti casi alzheimeriani, e in generale per altri tipi di patologie, si nota un’associazione tra aree cerebrali più selettivamente compromesse e segni o sintomi, che vengono perciò definiti “focali”, con relativa conservazione della memoria. Disfunzioni percettive e motorie collegate alla vista caratterizzano le atrofie corticali posteriori; difficoltà nei gesti (aprassia) e nei calcoli caratterizzano le atrofie parietali bilaterali; alterazioni varie al linguaggio sono tipiche di sofferenza temporale; difficoltà esecutive indicano un coinvolgimento prevalente ai lobi frontali, come anche nelle forme fronto-temporali, dove spiccano i disturbi del comportamento (Alberici, et al., 2014).
Trattamenti innovativi: due studi pilota
Due recenti articoli illustrano nuove opportunità terapeutiche per le persone con demenza, includendo pazienti “giovani”. In entrambi i casi, si tratta di sperimentazioni cliniche controllate mediante stimolazioni transcraniche, da concepire come trattamenti aggiuntivi: per via magnetica e per via ultrasonica.
Riguardo al trattamento per via magnetica (Jung, et al., 2024), sono stati studiati 18 donne e 12 uomini, reclutati presso ambulatori per la memoria nella Corea del Sud, di età compresa fra 56 e 84 anni (età media quasi 70), con deterioramento cognitivo lieve o demenza lieve (Mini Mental State Examination – MMSE medio 22,5 / 30 ± 3,6), entrambi da malattia di Alzheimer. 18 partecipanti sono stati sottoposti, nel corso di 4 settimane, a 21 sessioni di stimolazione magnetica transcranica, progettata sulle loro caratteristiche individuali, misurate attraverso analisi di connettività mediante risonanza magnetica funzionale eseguita in condizioni di riposo. Nel medesimo lasso di tempo, 12 partecipanti hanno ricevuto stimolazioni simulate. Le procedure – simili a quelle applicate con efficacia per la depressione resistente ai farmaci – sono risultate sicure e ben tollerate, senza che si siano verificati eventi avversi rilevanti.
Durante la sperimentazione si è aperta una forbice che ha separato le traiettorie delle due forme di stimolazione (vera / simulata), rispetto a tutte le misure principali di esito: cognitivo, funzionale e misto, misurati rispettivamente mediante le scale di valutazione ADAS-Cog Alzheimer’s Disease Assessment Scale (totale e voci specifiche), IADL Instrumental Activities of Daily Living, CDR-SOB Clinical Dementia Rating Scale-Sum of Boxes. I 3 parametri sopra indicati, mentre puntavano verso il miglioramento con la stimolazione vera, tendevano invece a peggiorare in quella simulata, così da raggiungere differenze rispettivamente di oltre 4 punti (ADAS-Cog), oltre 2 punti (IADL) e meno di 1 punto (CDR-SOB).
La tendenza era ben visibile già al termine della fase di intervento; 4 settimane dopo l’ultima stimolazione, veniva raggiunta la significatività statistica su tutti i 3 parametri, mentre per quanto riguarda l’indicatore cognitivo (ADAS-Cog) l’effetto assumeva rilevanza clinica; i benefici non differivano in ragione dello stato cognitivo (deterioramento cognitivo lieve amnestico o demenza lieve). Gli aumenti ottenuti nella connettività tra regioni del cervello importanti per la memoria – indicativi di un rinforzo a lungo termine nei collegamenti fra le cellule cerebrali – erano correlati ai miglioramenti cognitivi all’ADAS-Cog.
Ancor più recentemente è stato pubblicato il primo studio clinico randomizzato controllato che ha confrontato una stimolazione ultrasonica vera con una simulata, in malati di Alzheimer (Matt, et al., 2025); lo studio è stato condotto da ricercatori del dipartimento di neurologia dell’Università di Vienna, nell’arco di 5 anni. La scelta della stimolazione mediante ultrasuoni – piuttosto che impulsi elettrici o magnetici – riposa su motivazioni dichiarate: la possibilità di effettuare modulazioni non invasive, focalizzate precisamente, su strutture cerebrali profonde, senza interferenza da eventuali anomalie delle strutture nervose.
Hanno preso parte alla ricerca 60 partecipanti (30 femmine) di età media 70,65 (± 8,16), che sono stati suddivisi in 2 gruppi, sottoposti a sequenze di 6 stimolazioni reali (“verum”) e di 6 simulate (“sham”), a cicli incrociati nell’arco di 2 settimane. Il punteggio medio al MMSE dei partecipanti era 23,77, con 44 pazienti con diagnosi di demenza di Alzheimer in stadio lieve (MMSE 26-18) o moderato (MMSE 17-10), e 16 con deterioramento cognitivo lieve di natura alzheimeriana (MMSE 30-27). Quale indicatore principale di risultato è stata scelta una misura cognitiva frequentemente adoperata nelle indagini sulle terapie per la demenza di Alzheimer: il CERAD CTS, Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease (CERAD) corrected total score (CTS). La mancanza di consapevolezza nelle persone trattate rispetto alla condizione “verum” / “sham” è stata garantita mediante opportuni accorgimenti tecnici.
Dopo quella basale, le rilevazioni degli effetti sono state condotte subito dopo la serie di stimolazioni, e dopo 1 e 3 mesi. Sebbene diversi pazienti di età superiore ai 70 anni abbiano tratto beneficio dalla stimolazione in condizione “verum”, solo il sottogruppo più giovane (≤ 70 anni) ha mostrato aumenti al CERAD CTS significativamente più elevati per lo stato “verum” in tutte le sessioni post-stimolazione. A 3 mesi dalla fine della terapia, per esempio, la differenza nei punteggi al CERAD CTS fra stimolazione vera e simulata era 5 volte maggiore nei “giovani” rispetto alla media dell’intero campione. Tra i risultati secondari, sono stati ottenuti benefici per le attività ricreative auto-riferite e per le capacità di riconoscere volti di persone, indipendentemente dall’età, e sulla sintomatologia depressiva (rilevata mediante BDI-II Beck Depression Inventory-II): qui però solo per gli ultra70enni.
Studi pilota come quelli citati vanno presi con cautela: meritano però di venire seguiti con attenzione, dato che indicano strade quanto meno complementari ai trattamenti convenzionali, fondate su solide basi neurobiologiche e certamente meglio gestibili, da vari punti di vista, rispetto a interventi per molti versi più impegnativi.
Note
- Applicando un simile conteggio alla composizione per età della popolazione di Abbiategrasso, la cittadina a ovest di Milano che ospita la Fondazione Golgi Cenci e l’Istituto Geriatrico Camillo Golgi, si potrebbero trovare approssimativamente 15 ammalati, sui circa 15.000 abbiatensi di età compresa fra 30 e 64 anni.
- Rispetto alla condizione di astemio, è risultata protettiva un’assunzione di alcol moderata (≤ 14 g/die per femmine, ≤ 28 g/die per i maschi).
Bibliografia
Alberici A., Benussi A., Premi E., Borroni B., Padovani A. (2014), Clinical, genetic, and neuroimaging features of early onset Alzheimer disease: the challenges of diagnosis and treatment, in Current Alzheimer Research, 11(10):909-917.
Filippini T., Vinceti M. (2023), Social disparities and unhealthy lifestyles increase risk of dementia, particularly at a young age, in The Lancet. Healthy Longevity, 4(12):e660-e661.
Hendriks S., Peetoom K., Bakker C., Koopmans R., van der Flier W., Papma J., Verhey F., Young‐Onset Dementia Epidemiology Study Group, de Vugt M., Köhler S. (2023), Global incidence of young-onset dementia: a systematic review and meta-analysis, in Alzheimer’s & Dementia: the Journal of the Alzheimer’s Association, 19(3):831-843.
Hendriks S., Peetoom K., Bakker C., van der Flier W., Papma J., Koopmans R., Verhey F., de Vugt M., Köhler S., Young-Onset Dementia Epidemiology Study Group (2021), Global prevalence of young-onset dementia: a systematic review and meta-analysis, in JAMA Neurology, 78(9):1080-1090.
Hendriks S., Ranson J.M., Peetoom K., Lourida I., Tai X.Y., de Vugt M., Llewellyn D.J., Köhler S. (2024), Risk factors for young-onset dementia in the UK biobank, in JAMA Neurology, 81(2):134-142.
Jung Y.H., Jang H., Park S., Kim H.J., Seo S.W., Kim G.B., Shon Y.M., Kim S., Na D.L. (2024), Effectiveness of personalized hippocampal network-targeted stimulation in Alzheimer disease: a randomized clinical trial, in JAMA network open, 7(5):e249220.
Li R., Li R., Xie J., Chen J., Liu S., Pan A., Liu G. (2023), Associations of socioeconomic status and healthy lifestyle with incident early-onset and late-onset dementia: a prospective cohort study, in The Lancet. Healthy Longevity, 4(12):e693-e702.
Li Z., Yang Y., Liu Y., Wang X., Ping F., Xu L., Zhang H., Li W., Li Y. (2024), Global burden of dementia in younger people: an analysis of data from the 2021 Global Burden of Disease Study, in eClinicalMedicine, 77, 102868.
Matt E., Mitterwallner M., Radjenovic S., Grigoryeva D., Weber A., Stögmann E., Domitner A., Zettl A., Osou S., Beisteiner R. (2025), Ultrasound neuromodulation with transcranial pulse stimulation in Alzheimer disease: a randomized clinical trial, in JAMA network open, 8(2):e2459170.
Richmond-Rakerd L.S., D’Souza S., Milne B.J., Caspi A., Moffitt T.E. (2022), Longitudinal associations of mental disorders with dementia: 30-year analysis of 1.7 million New Zealand citizens, in JAMA Psychiatry, 79(4):333-340.