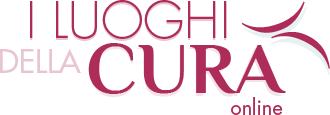Nati nel 1997 da un’idea del medico olandese Bère Miesen, gli Alzheimer Café sono luoghi di incontro, di sostegno e di orientamento per persone che vivono la demenza e per i loro familiari; sono spazi protetti e dedicati, in cui trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente centrata sull’ascolto, sulla relazione d’aiuto, sul piacere di stare insieme. Per chi vive la malattia, si tratta di un momento terapeutico in cui si possono mantenere attive le funzionalità sociali ancora presenti; per i caregiver, di uno spazio in cui apprendere informazioni sulla malattia e i suoi sintomi, parlare delle difficoltà legate all’assistenza, ricevere consigli e suggerimenti per fronteggiare la situazione.
Caratteristiche e obiettivi del progetto
Il Caffè Alzheimer “Tazzine di ricordi: bambini e anziani si incontrano” nasce da un incontro collaborativo tra la Cooperativa sociale Nomos e Lo spazio delle donne srls (in particolare, con il progetto Spazio Famiglia, attivo all’interno nel nido d’infanzia Il Giardino delle Tate a Scandicci).
Queste due realtà condividono una visione di presa in carico globale del nucleo familiare, mirata a costruire un progetto individualizzato per l’inserimento – da una parte dell’anziano, dall’altra del bambino – all’interno di un percorso inclusivo e costruito sulle capacità (più che sulle inabilità) dell’anziano o del bambino. Da questa visione nasce l’idea di far incontrare i bambini dell’asilo nido e gli anziani che, con i loro caregiver, hanno frequentato il Caffè Alzheimer nascente nel territorio di riferimento.
Il progetto si fonda su due interventi entrambi di natura inclusiva e con effetti positivi per tutti i soggetti coinvolti. Il Caffè Alzheimer si propone come punto di riferimento, luogo di incontro centrato oltre che sull’ascolto, sulla condivisione e sul sostegno alle difficoltà legate alla gestione della malattia, per cercare di rafforzare l’efficacia delle azioni di chi assiste e migliorare la qualità della vita di chi vive la malattia e dell’intero nucleo familiare.
Gli incontri intergenerazionali – come dimostrato da svariati esempi, nel contesto nazionale e internazionale (Cortellesi, Kernan, 2016; Gualano, et al., 2018) – portano benefici, osservabili fin dal primo incontro, a tutti gli attori coinvolti: l’anziano si relaziona spontaneamente con il bambino, prova gioia, prende più facilmente l’iniziativa e ha performance migliori rispetto ad altri contesti attivanti; il bambino si relaziona in modo spontaneo con l’anziano, mettendo in campo in modo innato un atteggiamento di reciprocità nello svolgimento di un’attività comune.
Gli obiettivi del progetto sono stati:
- contrastare la tendenza a non attribuire il giusto valore agli incontri intergenerazionali; ancora oggi si tende a tenere lontani i bambini dalle condizioni di malattia e di decadimento che possono esprimersi in tarda età, togliendo sia ai bambini che agli anziani l’opportunità di un incontro arricchente e di beneficio dal punto di vista dell’umore e della stimolazione delle abilità;
- combattere l’isolamento di coloro che vivono la demenza e dei loro familiari; spesso le persone con demenza, così come i loro cari, perdono i rapporti sociali significativi, vivendo in solitudine con i loro caregiver le difficoltà che la malattia porta con sé;
- sensibilizzare la popolazione sulla tematica della demenza; fare in modo che il Caffè Alzheimer si svolga regolarmente all’interno di un contesto come un asilo nido è un passo coraggioso e innovativo verso una comunità più consapevole e inclusiva sulla tematica della demenza.

L’esperienza si è svolta, con frequenza mensile, dal febbraio 2024 all’ottobre 2024. Sono stati coinvolti 12 anziani, con i loro caregiver, e 18 bambini. I genitori dei bambini sono stati resi partecipi dell’esperienza attraverso incontri di condivisione nell’ambito del progetto educativo, che in quell’anno verteva sulla cura. Sul fronte degli operatori, sono stati coinvolti:
- una psicologa esperta in psicogeriatria, che si è occupata di programmare le attività svolte dall’educatrice del Caffè Alzheimer, accogliere i familiari per svolgere attività di consulenza e orientamento, curare l’avvio di gruppi di sostegno/psicoeducazione per i familiari;
- un’educatrice professionale, che si è occupata delle attività ricreative proposte alle persone con demenza, coinvolgendo gli anziani e i loro caregiver nelle attività svolte all’interno dell’asilo nido;
- le educatrici dell’asilo nido, che hanno programmato, insieme agli operatori del Caffè Alzheimer, le attività da proporre nel giorno di compresenza all’asilo nido e hanno accolto, con alcuni bambini, gli anziani e i loro caregiver partecipando alle attività proposte.
L’importanza di uno scambio intergenerazionale
Non è nuova la realizzazione di progetti che vedono come protagonisti i bambini e gli anziani all’interno di un percorso inclusivo, volto alla collaborazione e alla condivisione, che tiene ben presente le peculiari caratteristiche personali dei partecipanti. Tali progetti intendono abbattere le barriere intergenerazionali che vengono poste dagli adulti: si tende ad allontanare i bambini dagli anziani, per “paura” e protezione da rischi e pericoli che non si presentano veramente nella loro relazione. La storia appena passata della nostra società ci ricorda, infatti, quanto “i nonni” siano utili in una formazione attiva e pedagogizzante nella vita dei più piccoli (Cesari Lusso, 2004; Corsi, Ulivieri, 2012; Di Sandro, 2013).
Non far vedere un decadimento naturale di quella che è la vita crea un tabù, che viene implicitamente assimilato dalle nuove generazioni, non permettendo ai più piccoli di relazionarsi in modo sano con persone che – pur presentando difficoltà oggettive – sono ancora capaci di amare in modo spontaneo, profondo e di insegnare, a modo loro, a sperimentare il mondo. Dall’altra parte, per l’anziano entrare in contatto diretto con i bambini permette di ri-sperimentare la scintilla di vitalità che caratterizza la giovane età, di vedere il mondo con gli occhi semplici e scintillanti, con cui soprattutto i più piccoli si approcciano alla realtà circostante. La relazione con soggetti così attivi e pieni di vita è fonte di stimoli fisici e cognitivi.
Jerom Bruner, eminente psicologo statunitense che ha contribuito in modo significativo alla psicologia cognitiva, culturale ed educativa, nel secolo scorso sosteneva, parlando di creatività, che essa era un processo generalizzato, comune a tutti indipendentemente dalla fascia d’età e che proprio questa facoltà poteva essere un punto fondamentale nell’educazione dell’individuo (Bruner, 1968).
Erich Fromm, altro luminare del ‘900, psicologo, psicoanalista e filosofo tedesco ha scritto: “Essere creativi significa considerare tutto il processo vitale come un processo della nascita e non interpretare ogni fase della vita come una fase finale. Molti muoiono senza essere nati completamente. Creatività significa aver portato a termine la propria nascita prima di morire. […] Educare alla creatività significa educare alla vita” (Fromm, 1972).
L’arte del gioco permea prepotentemente la nostra cultura: giocare, indipendentemente dalla nostra età, ci rende vivi. Scrive Freud: “Il grande Leonardo, a ben vedere, rimase tutta la vita per più versi infantile; si dice che tutti i grandi uomini conservino qualcosa di infantile. Continuò a giocare ancora in età adulta e anche per questo apparve talora inquietante e incomprensibile agli occhi dei suoi contemporanei” (Freud, 1969).
Dare l’opportunità, a soggetti fragili come possono essere gli anziani affetti da patologie neuro-degenerative, di entrare in contatto con i più piccoli permette quindi di riaccendere in loro una scintilla creativa, che apporta beneficio a tutta la persona. Lo scopo principale dei progetti intergenerazionali che coinvolgono anziani con demenza è contrastare lo stigma, stimolare le persone con demenza e migliorarne la qualità di vita, migliorando di conseguenza il rapporto con i caregiver.
Occuparsi di una persona con demenza è un compito arduo, molto impegnativo sia sul piano organizzativo che su quello emotivo, con limitazioni più o meno importanti nel normale svolgimento della propria vita. Stimolare la sensibilizzazione della società sulla tematica della demenza e attuare strategie di sostegno per i caregiver rappresentano interventi fondamentali per una società inclusiva.
La circolarità della vita
Di uso comune è sostenere la circolarità dell’esistenza: quante volte si afferma “da vecchi si ritorna bambini”? L’infanzia e la vecchiaia sono due fasi della vita che a uno sguardo disattento appaiono opposte: da una parte l’inizio dell’avventura della vita, dall’altra la sua conclusione. Una caratterizzata dall’innocenza che apre gli occhi con stupore all’esistenza, l’altra dalla saggezza di chi nella vita ha superato piccole e grandi sfide. La prima si manifesta nell’ardore dell’appassionata scoperta del mondo, l’altra nella tranquilla contemplazione della manifestazione.
Molto spesso il modo di relazionarsi con il mondo è simile. Entrambi sperimentano il difficile compito di farsi comprendere, di vivere una realtà nuova e complessa: nuova per il bimbo che si affaccia al mondo, nuova per l’anziano che deve reimparare a relazionarsi, con le sue difficoltà; tra questi estremi scorre il divenire. Sovente tendiamo a trascurare l’aspetto circolare della vita, impedendoci di sperimentare la sua valenza di permanenza, rendendoci impreparati a sostenerne una complessità oggettiva e soggettiva, considerando un processo lineare tra un passato e un futuro che non tiene però conto del momento presente. Queste due realtà agli antipodi nel corso temporale possono invece essere lette come due importanti principi organizzatori, che attraversano tutti gli archetipi in un movimento evolutivo continuo.
La spontaneità emotiva è comune, il linguaggio verbale con le sue difficoltà spesso è comune. La memoria, seppure per aspetti diversi, coincide: l’oblio della vita passata, spesso presente in persone con demenza, coincide con la mancanza sperimentale della vita dei più piccoli: scordarsi cosa abbiamo vissuto non è molto diverso da non averlo ancora sperimentato.
Lo stupore davanti a una foglia che cade, negli occhi del bambino, lo possiamo ritrovare senza difficoltà nel volto dell’anziano sulla panchina, in contemplazione della natura. Una mano tremante che si appoggia delicatamente su una guancia ha la stessa valenza emotiva di una piccola mano che compie lo stesso gesto. In questo clima la fa da padrona la semplicità istintuale del rapporto con l’altro, la ricerca di figure di riferimento che aiutino sia l’anziano che il bambino a sopperire a quelle che sono le proprie difficoltà.
Una mattina all’asilo nido
Sono le dieci, l’attività dell’asilo nido è già iniziata. Genitori affaccendati abbracciano i piccoli che vengono accolti dalle educatrici; tra un pianto e un sorriso i bimbi entrano nella routine della giornata: una giornata particolare, oggi arrivano “i nonni”. Arrivano insieme ai loro familiari, ancora un po’ assonnati ma curiosi e trepidanti per questa visita insolita. Si levano le giacche e indossano i calzari sopra le scarpe, per accedere alla sala comune. Si accomodano sulle sedie preparate in precedenza. Occhi lucidi di stupore si accendono, quando nella stanza entrano in fila indiana i bambini, che li ricambiano con i loro sguardi timidi e curiosi.
I primi sorrisi, i primi timidi avvicinamenti a questi anziani che molto spesso non si possono alzare, ma che con estrema delicatezza cercano un contatto. È il primo momento, quello della merenda, dove i bambini accomodati nelle loro seggioline guardano “i nonni”, sulle sedie grandi, fare colazione con loro. Una bevanda calda, uno snack e poi via alle attività. Si aprono “le danze”, si aprono i cuori e la distanza generazionale perde di significato. Piccoli “folletti” saltellanti con gli occhi grandi, affamati di sperimentare l’esistenza, coinvolgono gli anziani stimolando in loro l’atavica volontà di vivere.
E qui succede una vera a propria magia: basta una storia letta tutti in cerchio o una canzoncina intonata a far riaffiorare nella mente ricordi lontani, i figli e i nipoti ancora piccoli, la propria infanzia; la delicatezza dei ricordi passati si affaccia alla memoria e non è più una sbiadita reminiscenza, ma attraverso un salto temporale ci si ritrova a viverla in una stanza gioiosa.
I caregiver e noi educatori rimaniamo meravigliati davanti alla spontaneità che si crea: gesti di assoluta dolcezza che nascono dallo scambio vicendevole. Quelle che all’occhio dell’adulto sono lette come incapacità dell’anziano, non sono nemmeno prese in considerazione dal bimbo che guarda molto più alla sostanza che alla forma.
Le paure iniziali di noi educatrici, su come coinvolgere i due gruppi, diventano inconsistenti: il lavoro di amalgama è naturalmente attivo. Certo, alle spalle l’attenzione ai tempi dei soggetti, alle modalità di incontro, all’ambiente sono basilari: un attento lavoro di équipe viene premiato da sorrisi smaglianti. In tutti ci sono sorrisi felici; l’apatia che spesso caratterizza gli occhi di questi anziani viene spazzata via dalla forza della gioia dei bambini, così contagiosa che è impossibile resisterle. Vengono ripagati tutti quei piccoli sforzi che noi educatrici abbiamo messo in atto. In quel momento diviene chiaro come tutti i dubbi, tutte le paure siano ridondanti e superflui.
Le ore passate davanti alla televisione sono dimenticate, lasciano spazio alla fantasia che si veste di un piccolo fiore di stoffa incredibilmente profumato. Bolle di sapone soffiate da labbra tremanti che provano a ricordare come si fa, si poggiano su manine che cercano di acchiapparle. Voci, risate, sorrisi: è un turbinio di emozioni. Le paure di una sovrastimolazione sensoriale, che spesso si riscontrano nell’anziano con demenza, sono sostituite da commenti dolcissimi: “Hai visto come sono piccoli?”, “Guarda come saltano!”, “Ti ricordi quando i nostri figli erano così?”.

Le espressioni verbali sono state talvolta sorprendenti ed emozionanti; un anziano, con un grave decadimento cognitivo che ne ha compromesso anche le facoltà verbali, guardando i bimbi e poi girandosi verso un’educatrice ha sussurrato: “Angeli”. Ecco, in quella parola c’era la nostra vittoria; quella semplice parola commovente, uscita in un sussurro, ha reso vivo e sensato tutto il nostro lavoro.
Gli esiti del progetto
Durante l’attività è stata compilata una scheda di osservazione e monitoraggio, sia per gli anziani che per i bambini; nella scheda è stato attribuito un punteggio relativamente al grado di partecipazione, coinvolgimento, attivazione e al comportamento (in termini di presenza o meno di manifestazioni quali ansia, irritabilità o altro). I risultati sono stati positivi, sia rispetto al grado di partecipazione e attivazione in entrambi i soggetti, sia rispetto alla scarsità di eventi avversi circa il comportamento.
Quegli incontri sono stati un dono per tutti: per i bimbi, perché accrescevano le loro conoscenze sulla vita; per gli anziani, che ritrovavano lo scintillio all’esistenza; ma anche per tutti noi operatori, che abbiamo avuto modo di sperimentare quanto la paura del “diverso” sia infondata e inconsistente.
Gli esiti positivi del progetto indicano l’opportunità di replicare l’iniziativa e di approcciarsi anche alla scuola dell’infanzia. Quali aree di miglioramento sono state individuate la definizione dei requisiti di partecipazione per gli anziani (ad esempio non anziani in carrozzina) e il coinvolgimento nell’iniziativa di più asili nido (anche per il vincolo del numero di partecipanti a ogni incontro, determinato dagli spazi dell’asilo nido).
Riflessioni conclusive
Avere la possibilità di realizzare un Caffè Alzheimer in maniera continuativa all’interno di strutture come asili nido o scuole dell’infanzia è un passo coraggioso e innovativo, verso una società più consapevole e inclusiva sulla tematica della demenza.
È nostro compito insegnare alle nuove generazioni a non avere paura, non allontanandoli dai malati o dagli anziani, ma favorendo una condivisione inclusiva, evitando di instillare le nostre paure sulla vecchiaia e sulla morte, ma rendendo a queste dimensioni la loro naturalità. La grande ricchezza di questi progetti, e il compito come formatori e genitori, sta nello stimolare generazioni diverse a prendersi reciprocamente cura gli uni degli altri.
In un contesto come quello che si è presentato, il ruolo dei bambini e degli anziani non è quello di soggetti passivi da “educare”, ma di soggetti attivi con un ruolo formativo. Sono loro infatti che ci insegnano a non avere paura, a fidarci del nostro istinto emotivo, a leggere le persone esattamente come sono, senza categorizzarle in malati o sani, vecchi o giovani ma approcciandosi all’altro tenendo conto della propria peculiarità oggettiva, senza giudicarla.
La paura della vecchiaia associata alla morte, al dolore, alla perdita di facoltà perde di fondamento, rimane la persona esattamente così come è; si abbatte la paura e si mette in moto il cuore, che supera qualsiasi barriera che in un immaginario avrebbe potuto presentarsi. Creare un ambiente e un clima atto allo scambio spontaneo, tenendo conto delle personali difficoltà è stato il nostro compito. Il progetto non è rivoluzionario in sé, non abbiamo apportato niente di nuovo se non andare a riscoprire e riportare in luce quello che era un rapporto naturale nelle passate società. Rivoluzionaria è invece la voglia di scardinare quel muro verso l’altro, prima che sia così alto e cementificato da non poter più essere abbattuto.
Bibliografia
Bruner J.S. (1968), Il conoscere. Saggi per la mano sinistra, Armando editore.
Cesari Lusso V. (2004), Il mestiere di… nonna e nonno. Gioie e conflitti nell’incontro fra tre generazioni, Erickson.
Corsi M., Ulivieri S., a cura di (2012), Progetto generazioni. Bambini e anziani: due stagioni della vita a confronto, Edizioni ETS.
Cortellesi G., Kernan M. (2016), Together old and young: how informal contact between young children and older people can lead to intergenerational solidarity, in Studia paedagogica, 21(2):101-116.
Di Sandro E. (2013), Nonni e nipoti oggi. Una ricerca nell’Empolese Valdelsa, in Rivista italiana di educazione familiare, n. 2.
Freud S. (1969), Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, volume 1. Leonardo e altri scritti, Bollati Boringhieri.
Fromm E. (1972), L’atteggiamento creativo, in Anderson H.H., a cura di, La creatività e le sue prospettive, La Scuola.
Gualano M.R., Voglino G., Bert F., Thomas R., Camussi E., Siliquini R. (2018), The impact of intergenerational programs on children and older adults: a review, in International Psychogeriatrics, 30(4):451-468.